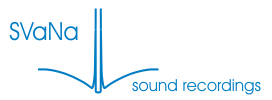L’Optimum Signal Stereo è una particolare tecnica microfonica che utilizza due microfoni omnidirezionali distanziati di circa 17 cm e separati da un disco di circa 30 cm di diametro. Il disco, noto anche col termine di Jecklin Disk dal nome dell’ingegnere svizzero che lo utilizzò per primo, è ricoperto da materiale fonoassorbente e la sua funzione è separare i due microfoni, differenziando la qualità del suono che li colpisce (sia in termini di differenze temporali che di differenze spettrali).
L’idea di questa tecnica è quella di simulare la presenza della testa tra le ipotetiche "orecchie" dell’apparato di registrazione. Questa tecnica si avvicina quindi a quelle più propriamente dette binaurali che utilizzano una vera e propria testa artificiale (o l’intero torso di un manichino) per dare una ancora più realistica riproduzione del panorama sonoro in cui si effettua la registrazione; però – a differenza delle tecniche binaurali "pure" che suonano perfettamente in cuffia ma eccessivamente colorate (cioè modificate nello spettro) in cassa per via delle superfici irregolari della testa artificiale – l’OSS riunisce i vantaggi delle normali tecniche semicoincidenti (ottima apertura stereo e localizzazione in cassa molto precisa) con quelli più tipicamente binaurali (dettaglio e profondità sonora impressionanti nell’ascolto in cuffia), costituendo una valido compromesso tra di esse (con una risposta alle basse frequenze eccellente [cfr. Bruce Bartlett 1991]).
Sebbene il suono prodotto dall’OSS sia molto soddisfacente in cassa e assolutamente straordinario in cuffia e sebbene diversi libri che trattano di tecniche microfoniche ne parlino in maniera generalmente entusiasta, l’OSS non è una tecnica diffusa quanto altre coincidenti o semicoincidenti. Probabilmente il suo (relativamente) raro utilizzo si spiega con il fatto che l’OSS riproduce molto fedelmente l’ambiente in cui si trova (tanto da evidenziarne anche i possibili difetti acustici), che non sia integrabile in una ripresa multimicrofonica (tanto in voga ai giorni nostri in quanto generalmente più "facile" delle riprese a due o comunque pochi microfoni) e forse anche perché produce musica che in riproduzione mono risulta eccessivamente colorata (si pensi alla trasmissione radiofonica AM e in genere al fatto che le tecniche di ripresa più diffuse sono proprio quelle utilizzate dai tecnici delle radio e delle televisioni – ORTF, NOS, RAI, etc.).
In SVaNa, si può dire, abbiamo adottato l’OSS per i motivi che hanno sancito il suo scarso utilizzo: infatti non pensiamo che ciò che registriamo sia fatto per essere riprodotto in mono ma bensì con la migliore riproduzione stereo possibile, e siamo convinti che in moltissime situazioni la qualità di ripresa garantita da questo sistema sia impareggiabile, una volta che si sia stati abbastanza abili da trovare il posto migliore per posizionare i microfoni nell’ambiente di ascolto in funzione di ciò che si vuol registrare e di come lo si vuol registrare.
SVaNa, rispetto alle specifiche standard dell’OSS, ne utilizza una versione leggermente modificata, in virtù sia dell’esperienza maturata con esso in varie situazioni (gruppi orchestrali, cameristici e solisti), sia degli studi di psicoacustica e ingegneria del suono successivi a quelli di Jürg Jecklin (ad es. Bluthard et al.): il disco SVaNa è leggermente più grande e lo strato isolante (di materiale sintetico) è più spesso, con una dislocazione microfonica (angolazione e distanza intermicrofonica) che viene modificata di volta in volta, a seconda degli strumenti e della musica da registrare e della configurazione che dà l’ascolto più soddisfacente.